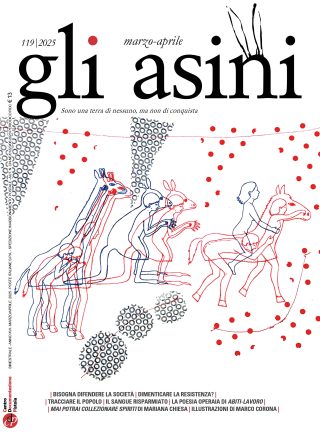- FOGLIO VOLANTE
- ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CANTASTORIE ON LINE 2
- PRESENTAZIONE
- CONTATTI
- ARTICOLI 2O23/2025
- ARTICOLI 2014 - 2022
- SEGNALAZIONI EVENTI
- CRONACHE EVENTI 2022 - 2025
- CRONACHE EVENTI 2013- 2021
- PERSONAGGI
- RECENSIONI
- BANDI e CONCORSI
- ASS. A.I.CA LORENZO DE ANTIQUIS
- NOTIZIE DALLA RETE E DINTORNI
- BURATTINI, MARIONETTE E PUPI
- CARNEVALI
- CANTASTORIE AL FEMMINILE
- ARCHIVIO CESARE BERMANI 2
- MAF MONDO AGRICOLO FERRARESE
- LINK
- ORACOLO
- La Rivista
- LA PIAZZA MILANESE
- CANTASTORIE PER UN'ITALIA ANTIFASCISTA
- CANTASTORIE E CORONAVIRUS
- CANTI BALLATE POESIE CONTRO TUTTE LE GUERRE
- CANTASTORIE IN PILLOLE

Marzo-Aprile 119 Nuova serie/2025
Centro di Documentazione di Pistoia
via Pertini snc, c/o Biblioteca San Giorgio – 51100 Pistoia
Proponiamo l'intervista integrale a Mauro Geraci raccolta da Livio Marchese e pubblicata sulla rivista "gli asini" di marzo-aprile 119 Nuova Serie/2025
Cantare le cose che non quadrano (o dell’attualità del cantastorie):
una conversazione con Mauro Geraci a cura di Livio Marchese
Mauro Geraci, docente di Antropologia culturale all’Università di Messina, ha dedicato una vita intera allo studio dei cantastorie, ambiente che ha frequentato sin dall’infanzia nella Palermo degli anni ‘60 e di cui si è reso egli stesso continuatore, componendo e cantando con maestri quali Franco Trincale, Vito Santangelo, Leonardo Strano. Recentemente ha autoprodotto una chiavetta USB, “L’insostenibile leggerezza dell’app. Storie di fallite modernità”, disponibile tramite il suo blog (geracicantastorie.it), contenente ventisei componimenti poetico-musicali autografi su temi attuali (il digitale, la pandemia, lo scollamento tra la politica-spettacolo e il paese reale, la trattativa Stato-mafia, la guerra, la vicenda della demolizione dello storico Teatro Nazionale di Tirana per speculazioni edilizie, ecc.), un pdf con i testi commentati dall’autore e un video.
Nel testo che segue, tratto da una lunga conversazione con il curatore, Geraci ragiona sull’attualità di una figura apparentemente arcaica come quella cantastorie e sul concetto di “popolare” nella società contemporanea.
Messina, 17 novembre 2024
Quando e come è iniziata la tua passione per il mondo dei cantastorie?
I primi ricordi risalgono a quando ero bambino. Mio padre lavorava come critico musicale e teatrale e a casa portava tantissimi dischi, tra cui anche quelli di cantastorie come Ignazio Buttitta, o anche Rosa Balistreri che ho conosciuto perché lui mi portava a sentire i concerti. La prima volta che ho visto Franco Trincale – che poi diventerà il mio maestro – è stato al festival Palermo Pop 70, dove suonarono i Led Zeppelin, Aretha Franklin, Duke Ellington e c’era anche Trincale. Cominciavo anche a imparare qualcosa a memoria e mio nonno m’incoraggiava. Quando ero un pochino più grande andavamo al Foro Italico dove c’erano le bancarelle che vendevano i dischi e lui me li regalava.
Poi ci siamo trasferiti a Roma e quel mondo mi mancava, anche se sopravviveva ancora la passione da parte dei siciliani emigrati, per cui veniva Otello Profazio che faceva delle ballate sui paladini di Francia, c’erano gli spettacoli di Mimmo Cuticchio, di Fortunato Pasqualino, c'era Buttitta che venne a rappresentare Colapesce. Insomma, un filone che ho continuato a seguire anche accostandomi al folk music revival. I cantastorie e il folk music revival sono due cose diverse, ma per certi aspetti si sono sovrapposte.
Poi mi sono scontrato con l’accezione che si aveva della cosiddetta cultura popolare negli ambienti studenteschi di sinistra. Era una concezione che non mi quadrava perché di Trincale, Busacca, Profazio, Balistreri si parlava con sufficienza, mentre si riteneva che cultura popolare fossero le launeddas sarde o la chitarra battente, la zampogna calabrese, cioè qualcosa di arcaico. Trincale che faceva un disco, Senso Vietato, sulle canzoni a doppio senso (ma lo faceva perché doveva sbarcare il lunario e quindi faceva comicità anche dissacrando), non veniva contemplato. Al punto che, più avanti, ebbi grosse difficoltà a far accettare la mia proposta di tesi sui cantastorie perché considerati troppo “ibridi”. A me però queste contraddizioni interessavano perché rappresentano la ragion d’essere dei cantastorie, che sono delle persone che vanno a cantare le cose che non quadrano, mettendo in gioco sé stessi. Poi ho incontrato l’antropologo Luigi M. Lombardi Satriani che è stato il mio correlatore di tesi e ha scritto un libro meraviglioso, Folklore e profitto. Appena gli ho ventilato il tema dei cantastorie mi ha molto incoraggiato ed è incominciato quel lavoro di ricerca che ha portato nel ‘96 a Le ragioni dei cantastorie [Id., Il Trovatore, Roma 1996].
Qual era nella società premoderna il ruolo del cantastorie e quali erano le peculiarità dei cantastorie siciliani rispetto a quelli di altre regioni?
Bisogna intendersi sui termini “moderno” e “premoderno”. Modernità è un termine relativo e usarlo in ambito scientifico è improprio. La modernità è anche fatta di passato, quindi come possiamo isolarla? Io penso che bisognerebbe differenziare per aree: per quanto riguarda la Sicilia, la vulgata comune è la ripresa automatica di certe colorazioni folkloristiche, secondo cui i cantastorie risalgono ai giullari medievali e addirittura a Omero. Non è assolutamente così. Questa del cantastorie siciliano è una figura che in Giuseppe Pitrè e negli altri folkloristi non è presente. Lui parla della canzone narrativa di tradizione orale, parla del cunto, parla dei cantastorie orbi, ma sono un’altra cosa. Di Alessandro Castro, ad esempio, che è fra i primissimi cantastorie, non trovi minimamente traccia. Il cantastorie è una figura che nasce subito dopo la Prima guerra mondiale con la letteratura muricciolaia e i giornali di cronaca che si cominciano a distribuire a livello nazionale e si trovavano dal barbiere, oppure trovavi nella merceria dei fogli volanti in cui poeti locali raccontavano fatti di cronaca e li scrivevano anche in italiano. Con il costruirsi di una cultura non locale ma rivolta anche all’esterno, si afferma l’esigenza di un mestiere girovago legato all’informazione, un’attività artigianale legata alla parola, alla musica, alla pittura, al disco, al foglio volante e al libretto che poi veniva venduto in piazza. Questo non significa che non esistessero prima elementi folklorici, estrapolati da altri contesti, messi assieme e posti alla base della figura nascente del cantastorie. Ad esempio il recitativo della mascherata carnevalesca esisteva nella cultura contadina. I cantastorie se ne appropriano per unirlo a una musica che non era soltanto quella contadina, ma che comincia a essere la musica della canzone leggera italiana e napoletana che si andava affermando. Carpitella diceva che per capire i cantastorie bisogna fare riferimento alla cosiddetta zona di mezzo. I cantastorie sono dei mediatori tra colto e popolare, tra cultura orale e scritta, ma anche tra musica, pittura, gesto, teatro. E anche per la morale: loro ricercano un punto espressivo terzo da cui raccontare al pubblico i contrasti. La funzione è informativa e commerciale, ma assume anche toni di denuncia. I cantastorie cominciano a cantare i drammi della povera gente: Buttitta scrive le storie dei sindacalisti ammazzati; Busacca, nel ’51, scrive L’assassinio di Raddusa, la storia di una donna che si vendica uccidendo il suo stupratore; nel ‘39, in pieno fascismo, Turiddu Bella scrive La vittoria delle donne, sull’emancipazione femminile; per non parlare delle critiche al fascismo sottese nelle cose di Orazio Strano e Turiddu Bella, come Guerra, discursi e fami, ragionamento di un patri con un figghiu. Certo, Buttitta diceva “noi siamo figli di Omero” e Busacca diceva “siamo giullari del Medioevo”, però da un punto di vista filologico non è così. Lo facevano per accreditare nel passato la loro forma d’arte che però, a un’attenta analisi della documentazione, è un fatto che nasce con la modernità. Il cantastorie è sempre l’avanguardia. Trincale, a 70 anni, si è fatto i siti da solo, Santangelo ha dedicato una poesia al microfono… non è che se ne andavano a cantare nelle aie dove si faceva la mietitura del grano o dove si faceva la pesca del tonno… bensì negli ambiti moderni, pubblici, innovativi della piazza. Gli antropologi li hanno fatti spesso passare come arcaici ma non è così e il concetto di modernità va preso con molta attenzione.
Quanto detto non significa che non ci siano prima della cosiddetta modernità figure analoghe. I rinaldi a Napoli, ad esempio, che però si occupavano sostanzialmente di temi epico-cavallereschi, oppure i cuntisti. Ma mentre in Sicilia è presente l’elemento legato al riscatto, alla denuncia sociale, alla drammaticità, nel nord si afferma quest’altra figura più legata alla canzone satirica, alla deformazione grottesca. Né la ritrovi nei cantastorie dell’Italia centrale, che cantavano per lo più leggende, penso a quel filone che poi arriva al cabaret romano, a Checco Durante, a Trilussa, prima ancora a Belli, quella poesia che affrontava la storia contemporanea attraverso i bozzetti e la caricatura.
La “piazza” è sempre stata il luogo d’azione fisico del cantastorie. Michele Straniero, nel 1970, nella prefazione al libro “Le ballate di Franco Trincale”, alludeva anche a un valore simbolico, scrivendo che “la piazza è la condizione della libertà, dovunque essa sia e dovunque può essere”. Com’è cambiato il rapporto tra il cantastorie e la piazza con l’avvento della televisione prima e, oggi, del digitale?
Vito Santangelo nella sua autobiografia racconta che da una piazza fisica in cui suonava con Paolo Garofalo, uno dei padri dei cantastorie di Paternò, si arrivò, anno dopo anno, a una piazza che diventava sempre meno libera e gestita da altri. Cominciava l’impresa dello spettacolo di piazza, degli artisti di strada. Di fatto, in nome di un’apertura si chiudevano spazi per i quali ottenere i permessi era difficile. Poi, quando i cantastorie cominciarono a schierarsi a sinistra, a legarsi a movimenti di denuncia, le piazze vennero anche proibite. La piazza dal punto di vista architettonico oggi non è più praticata dai cantastorie, tranne i tentativi disperati che stiamo facendo a Paternò per la riapertura di piazza ‘A Urna, che è una delle piazze storiche dove i cantastorie si esibivano liberamente. Questo significa che i cantastorie sono morti? No, perché la piazza architettonica non era e non è l’unico sito in cui i cantastorie si esibivano e si esibiscono. Dobbiamo distinguere tra la piazza come luogo scenico di esibizione e la piazza come canale. Il luogo scenico tradizionalmente è la piazza. Un tempo c’erano anche le sagre, le feste paesane. Le storie di santi, per esempio, si legano alle feste patronali di vari paesi. Ma i cantastorie andavano a cantare anche ai battesimi, ai matrimoni, alle commemorazioni, un po’ come fanno oggi i neomelodici. Contemporaneamente però, siccome la modernità porta all’apertura di spazi come quelli radiofonici, televisivi, cinematografici, i cantastorie si accostano anche a queste piazze mediatiche. Oggi le chiameremmo piazze virtuali, come internet e i social. Prima lo è stata la radio (tu pensa che Profazio inizia con Filogamo), la televisione (ricordo Trincale che cantava in prima serata “io sono nato laggiù in meridione e voglio fare la rivoluzione” nel 1982, su Rai3, alle otto e mezza di sera!), “Italia bella, mostrati gentile”, la trasmissione curata da Buttitta. Ma c’è anche una piazza “ideale”, la piazza intesa come circuito socio-culturale. Un circuito era sicuramente quello bracciantile nella Sicilia degli anni cinquanta. Poi è diventato il circuito operaio e dell’emigrazione, per esempio con Trincale che si stabilisce a Milano. Non lo facevano cantare in centro, se ne va in periferia dove ci sono le fabbriche e si crea un sodalizio con gli emigranti e gli operai. Poi c’è la piazza discografica: sui dischi c'era sempre il telefono del cantastorie, per mettersi in contatto con lui e farsi mandare i dischi. Io in Svizzera e in Germania ho ricostruito tutti i traffici di dischi che c’erano tra gli emigranti e i cantastorie. Ma accade anche questo: siccome attrae molto l’idea di avere un’informazione non mediata, fatta artigianalmente, non dai professionisti… del genere “sentiamo un’altra campana”… e questa piazza piace tanto alla sinistra quanto alla destra, spesso anche la destra si trova a scritturare dei cantastorie. E i cantastorie… ci vanno o non ci vanno? C’è un motto dell’Associazione Italiana Cantastorie che è “amici con tutti”. Allora, se tu mi fai cantare senza censure, io vado dappertutto. Anzi io parlo con quelli che la pensano diversamente e, come Buttitta, chiedo: “chi mi cuntati?”. Io parlo pure con i naziskin. Il dramma della sinistra di oggi è che non parla più con questi. Le borgate sono preda della destra… e invece il cantastorie ha proprio la funzione di instaurare un dialogo con chi non ha voce, magari anche di portare le persone dalla propria parte, ma in modo aperto, in modo dialogico, non in modo sotterraneo e truffaldino. Un disco di Trincale s’intitola Il provocantore: è la “provocanzone”... la bellezza del cantastorie è cantare nelle piazze dove non ti conoscono e magari anche ricevere complimenti da una piazza “straniera”. Da qui le bellissime descrizioni della piazza che fa Buttitta: “sugnu un giardinu di ciuri/ e mi spartu a tutti/ una cassa armonica/ e sono pi tutti/ un agneddu smammatu” (anche se sono palestinesi, israeliani, vietnamiti, ucraini) “e chianciu per tutti l’agneddi smammati”. Forse, sai, i cantastorie hanno avuto proprio il merito di aprire questa dimensione universalistica nell’ambito della cosiddetta cultura popolare, un po’ come avveniva nella tragedia greca, in cui si potevano affrontare i fatti non risolti, si poteva prestare la propria voce a quelli che non ce l’hanno.
A proposito di piazze, mi piacerebbe che spendessi qualche parola sul progetto “Paternò e le piazze del mondo” che in questi mesi stai portando avanti con l’Associazione cantastorie Busacca.
Abbiamo lavorato tantissimo con Francesca Busacca. Lei sta facendo delle cose straordinarie a Paternò, in modo avveduto e anche umile. Umile significa non usare la parola “cantastorie” per fare altro, giocando sul fatto che piace l’arcaico, perché in quel modo tu tradisci doppiamente il cantastorie, perché lo fai passare per arcaico e perché lo usi per progettualità che non sono legate a quella specifica dimensione conoscitiva che viceversa va promossa. Abbiamo presentato questo progetto, proponendo un calendario di sei incontri, di cui uno a Roma, all’Archivio Centrale dello Stato, sul cinema dei cantastorie. Perché l’arte dei cantastorie non è solo un fatto musicale. Carpitella, in un bellissimo saggio del ‘61, Retrospettiva del cantastorie, diceva che l’atteggiamento dei cantastorie nei confronti della musica è di profonda indifferenza. Nel senso che la musica è solo una delle componenti della sua arte. Non è un fatto estetico, di bravura vocale. Le voci dei cantastorie non sono “belle”. Questo è secondario. È quello che ha scritto, dove ha cantato, le lotte che ha portato avanti. Per questo viene ricordato un cantastorie, non certo per la voce. E anche quando cantavano dei fatti di sangue (che, tra l’altro, conoscono un momento di recrudescenza micidiale e che nascondono questioni universali, maschilismi mai sopiti, disagi economici mai affrontati e risolti, quelli che prendono a botte i medici e gli infermieri rispetto a una sanità che risulta sempre più fatiscente agli occhi di chi la sovvenziona). Questo progetto vuole promuovere, rispettare, proseguire il fatto “filosofico”, il pensiero dei cantastorie. “Paternò e le piazze del mondo” perché Santangelo, Busacca e gli altri non sono di Paternò, sono del mondo. Tant’è vero che cantavano in tutto il mondo. Santangelo ha cantato a Metz. Nella sua autobiografia racconta la sintonia che stabilì con i griot africani che incontra in Francia. E poi canta in un film di Ugo Gregoretti e incide per case discografiche di Milano e Torino. Io provocatoriamente dico che i cantastorie non sono siciliani, nel senso che, certo, è una figura che qua prende piede, ma per cantare questioni etiche di carattere universale.
Quando e come hai sentito l’urgenza di metterti in gioco in prima persona come cantastorie?
Rispetto agli antropologi dell’800 che pensavano di potere studiare senza muoversi dalla propria stanza, utilizzando i dati di mercanti e medici (non raccolti di prima mano), ai primi del ‘900 Malinowski individua come metodo l’“osservazione partecipante”. Cioè, tu non solo devi osservare, ma a qualche livello devi anche capire il punto di vista “altro”. Nel mio caso è venuto facile perché l’osservazione partecipante con i cantastorie è immediata. Sono uomini di piazza, di spettacolo, pronti a parlare con tutti. Non è andare a studiare le formule magiche delle maghe guaritrici delle Isole Eolie che non te le dicono manco scannate. In secondo luogo, io facevo l’antropologo e loro i cantastorie, però io notavo le analogie tra le due attività e mi dicevo “ma guarda qua, io faccio delle ricerche per le quali mi devo documentare, osservare, parlare con loro, frequentare le piazze dove loro si esibiscono, parlare con i testimoni, con il pubblico, e loro, quando scrivono le loro storie di vita, prima si devono documentare, osservare, leggere gli atti processuali, i giornali, sentire la televisione… alla fine io faccio un saggio e loro invece scrivono un saggio sotto forma poetico-musicale e poi lo espongono a un pubblico… ma non è che il cantastorie è l’antropologo della canzone?”. Perché chi l’ha detto che la filosofia è prerogativa di Kant, Hegel e di quattro elitari? Tutti gli uomini riflettono sul cosmo, sul loro stare al mondo, sullo scorrere del tempo. Rocco Scotellaro, in Contadini del sud, scopre la filosofia dei pastori della Basilicata; ma anche Danilo Dolci, in Non esiste il silenzio, frutto di incontri maieutici, scopre la filosofia nelle varie parti sociali della Sicilia dell’epoca; o Pasolini con le borgate romane; oppure ancora Goody, antropologo di Cambridge, insieme a Horton, filosofo, scoprono la filosofia nei cantastorie africani. Per cui mi sono detto “e se invece di scrivere un saggio queste cose le scrivessi in una canzone?”. Così ho provato e loro, Trincale, Santangelo, erano contentissimi, perché c’è pure un fatto di trasmissione del sapere. Quindi ho riconosciuto una sintonia tra la parola antropologica e la parola cantata. Sono due parole che indagano sulla realtà, che ricercano, tutt’e due, punti di vista esterni. Del resto Trincale ha fatto una battaglia per essere riconosciuto nell’ordine dei giornalisti; Turiddu Bella ha scritto un sacco di articoli per la rivista “Il cantastorie”, Buttitta pure. Non sono figure soltanto spettacolari, sono intellettuali. L'attività dei cantastorie, anche quando si fanno intervistare, quando si esprimono sui fatti senza fare poesia, diventa un punto di riflessione simile a quello proprio dell’antropologo. Il cantastorie si rivolge alla piazza, l’antropologo ai cosiddetti addetti ai lavori, in primis, ma poi si spera che questo sapere antropologico abbia una ricaduta più ampia.
Tu sei critico nei confronti di certi aspetti della modernità. Molti tuoi testi ironizzano contro il digitale, paradossalmente però gestisci un blog e hai pubblicato recentemente una chiavetta USB, “L’insostenibile leggerezza dell’app. Storie di fallite modernità”, contenente un gran numero di tuoi componimenti. Come sono nate le idee della chiavetta e del blog?
La modernità non deve piacere o non piacere. C’è e ci ritroviamo calati. Se modernità significa avere la possibilità di farsi conoscere di più, io non la rifiuto: lo scopo è di farsi sentire dal più vasto pubblico possibile e in questo senso la modernità ben venga. Il problema nasce quando in nome di una cosiddetta modernità si fanno tutta una serie di operazioni che contrastano con la libertà di parola e pensiero. La chiavetta USB è bellissima perché ti consente di essere fruita in macchina, un po’ come lo erano le cassette, ma in più ti consente di mettere maggiormente alla portata del pubblico il rapporto tra il prodotto poetico-musicale e le fonti che tu hai consultato, per cui tu puoi avere una fruizione musicale, ma puoi avere anche una fruizione audiovisiva, oppure documentale. Ad esempio, ho scritto recentemente una canzone su Satnam Singh, quel povero indiano che è stato buttato in mezzo alla strada con un braccio sanguinante… magari potrei inserire qualche articolo di giornale, qualche intervista. Ho anche fatto una ballata su Antonello da Messina: potrei inserire i dipinti, le critiche, le interpretazioni degli storici dell'arte, i luoghi da visitare. Aggiunge una nuova funzione: il cantastorie che propone non soltanto la sua voce, ma anche le voci degli altri.
Come scegli i temi da affrontare?
Le cose che ti colpiscono e che hanno delle contraddizioni plateali. Ti faccio un esempio. Se tu leggi tutte le storie della mafia, scopri come ha proliferato anche grazie alle assoluzioni. Addirittura nel caso di Salvatore Carnevale misero l’unico testimone diretto nella stessa cella con i quattro principali indagati… e anche la vicenda Giuliano, quante contraddizioni! Allora, fino a questo punto, uno capisce che purtroppo ci sono delle forme di collusione. Ma quando assolvono pure quelli della trattativa Stato-mafia, alcuni perché prescritti, altri perché il fatto non sussiste, altri ancora per insufficienza di prove, cioè le tipiche assoluzioni storicamente concesse ai mafiosi… si continua a infierire pure sul cadavere di Borsellino, anche dopo che è stato giustamente divinizzato! Ciò è inconcepibile! Il fratello di Borsellino ha detto: “Paolo aveva una cultura giuridica unica, aveva fatto delle ricerche… quest’assoluzione vuol dire che mio fratello è morto per non fare niente…”. E quella frase diventa l’elemento che mi dà il titolo, cioè io prendo un pezzo di una testimonianza diretta e lo faccio diventare titolo di una canzone: “Muriu me frati pi non fari nenti”. Il giornale è una fonte importante. Una volta c’era il trafiletto di un rumeno che andava a dormire sotto un camion a Torino. Un’altra volta un trafiletto è diventato una canzone di venti minuti: raccontava di uno che d’estate, con il caldo, si è presentato nella spiaggia di Mondello con una bambola gonfiabile. L’ha gonfiata, se l’è distesa accanto, le aveva messo l’anello e si rivolgeva a questa bambola amorevolmente, come fosse la moglie. Poi chiamano i carabinieri, gliela portano via e viene accusato di atti osceni, ma non lui non aveva fatto niente. Per loro già il fatto di avere la bambola era un atto osceno. Allora io mi sono messo a scavare e ho scoperto che questo pesava 250 kg, aveva una madre terribile, era vissuto isolato e a un certo punto aveva fatto una sorta di rivolta di Spartaco… e in fondo, che stava facendo? Assolutamente niente. Era plastica: lo stesso moplen che la modernità pubblicizza sin dagli anni ‘60! Ma ci possono essere anche situazioni occasionali. Per esempio adesso devo andare a cantare al Policlinico di Messina per uno spettacolo di beneficenza. In questi casi i cantastorie sono sempre disponibili. Non hanno i soldi per rifare l’arredamento dell’Hospice dove ci sono i malati terminali, allora hanno pensato di fare un concerto. Mi hanno chiesto di esibirmi e di mettere in poesia e in musica il mito di Cura, una dea greca, poi diventata romana, che lotta con Zeus e si ritrova contro tutti gli dei. Alla fine, viene declassata a dea minore e questo significa (cosa che lei viceversa prende con grande impegno) che si dovrà occupare dei corpi mentre sono in vita, mentre quando diventeranno spiriti se ne occuperà Giove mentre da morti se ne occuperà Gaia, la terra, perché è lei che ha dato l’argilla per costruirli. Ho ripreso il mito da Igino e ho scritto una storia che dura venti minuti e la devo andare a cantare lì. La piazza non c’è solo quando ti esibisci ma è anche prima ed è bello e stimolante andare in un posto e cantare una cosa fatta apposta per quell’occasione.
Da alcuni anni è in corso una riscoperta da parte di molti artisti mainstream della musica popolare. Penso ad esempio a Carmen Consoli che rifà la Balistreri. Che ne pensi al proposito?
Penso che folk revival era quello degli anni ’60, fino ai primi anni ’80, quindi in ogni caso sarebbe folk revival del folk revival, perché già Rosa Balistreri solo in minima parte ha fatto la cantastorie. Anche se era a contatto con i cantastorie, però, di fatto, era una donna che ha avuto una vita disgraziata ed è stata scoperta nell’ambito del folk music revival e quindi riproponeva in questa realtà ninnenanne, canti di carcere e mafia, canzoni d’amore, canzoni del venerdì santo, proverbi, con quella sua incredibile vocalità. Io in questo ripescaggio non vedo né delle motivazioni di carattere filologico né politico. Non c’è neanche un recupero della tradizione popolare in termini di contestazione, come faceva negli anni ‘70 la Nuova Compagnia di Canto Popolare. Ci vedo solo un fatto di esibizionismo, neanche folkloristico, perché i gruppi folkloristici lo fanno in modo più manifesto, a uso e consumo dei turisti. Qua invece ci vedi una sorta di etnicismo, che però riprende solo alcuni elementi e li inserisce in progetti “canzonettistici”. Sono, ahimè, delle operazioni commerciali. Quasi che loro vogliano farsi accreditare come dei continuatori, ma tra Rosa Balistreri e Carmen Consoli c’è l’abisso. E poi c'è questa chiave femminista che in Rosa Balistreri non c’era. Lei cantava le donne, ma non era quello… semmai c’era molto di più in Rosina Gioiosa Trubia, cantante palermitana dei primi del ‘900 che, ne La storia di Rosetta, cantava sullo stupro. Io ci vedo anche una violenza sul fatto che sono morti e non possono più parlare. Con Rosa lo possono fare, perché Rosa era da sola. Su Busacca già lo possono fare di meno. Sai anche perché? Rosa si presta, nel senso che faceva delle cose brevi, ma Busacca… la cosa più breve dura venti minuti. Magari riprendessero Busacca! Ma non solo Busacca… il progetto dei cantastorie… io sarei contentissimo. Il mondo ha bisogno di cantastorie, non che ci prendiamo un termine per poi consegnarci a un genere di cassetta. Vedo tante velleità, politiche, antropologiche, etiche, però, alla fine, si tratta di una strumentalizzazione finalizzata a farsi lo spettacolino. Magari Carmen Consoli no, perché lei scrive, ha una sua poetica, però trovi tanti artisti che si fanno passare per cantastorie che non hanno mai scritto un rigo, quando la cosa fondamentale per i cantastorie è l’osservazione, l’ascolto della voci degli uomini come le chiamava Buttitta, quindi la scrittura critica, non lo spettacolino. Prima c’è tutta una fase di osservazione, di concezione, di scrittura, parlare con le persone, trovare i versi giusti, le rime giuste per non fare offendere quello, per non fare offendere quell’altro. Dopo di ciò, porti la storia in piazza, spesso nell’ambiente da cui tu hai appreso le informazioni, dice Trincale, “per fare esplodere le contraddizioni”. Lui dice: “Io parlo con gli operai, gli emigranti… ma quali problemi avete? E loro: ti racconto la mia storia, oppure ti mando una lettera con la mia storia”. Il cantastorie mette assieme queste cose e ne tira fuori ballate che va a cantare proprio negli stessi ambienti, perché quelli adesso la propria storia se la comprano sotto forma di disco, quindi lui ha un ritorno economico e loro hanno un ritorno conoscitivo, perché è come se si guardassero allo specchio tramite la restituzione poetico-musicale della loro stessa storia, che adesso è diventata ballata, è disco.
Come diceva Buttitta: “l’omu è un puzzu, ‘u poeta cala ‘u catu e tira acqua pulita”. Il poeta va al cuore degli uomini e tira l’acqua pulita, cioè quello che l’omu non riesce a vedere, perché ce l’ha dentro di sé, il poeta glielo tira fuori e glielo fa vedere fino a fargli dire: “ma veramente questo io ho vissuto?”.
Oggi ci sono altri cantastorie in Sicilia che intendono il loro ruolo non in senso folkloristico o di sfruttamento di stereotipi funzionali al consumo, ma come una coscienza critica, come un tarlo che s’interpone tra il pensiero unico dominante e l’individuo allo scopo di metterne in crisi le certezze?
Sì, ad esempio Giacomo Sferlazzo, che ha cantato nell’ambito del nostro progetto. Mi è piaciuto moltissimo il suo modo di raccontare Lampedusa. Attraverso la storia di Andrea Anfossi della fine del ‘400, attraverso un uso nuovo della chitarra e della voce, facendo anche delle citazioni opportune, in un suo progetto nuovo di storia narrativa – perché lui dà anche tutti i riferimenti cronologici della vicenda –, ha messo in scena un luogo di culto che è stato, fino all’altro ieri, luogo di culto da parte dei musulmani e dei cristiani. Quindi facendo vedere come quell’Islam, che noi pensiamo prerogativa di un mondo antitetico, terroristico, è invece realtà con cui facciamo i conti da secoli. Un altro è Nino Racco, di Bovalino, molto vicino ai cantastorie di Paternò anche per quanto riguarda gli aspetti teatrali e l’uso della gestualità. Poi c’è Paolo Zarcone a Bagheria, Peppino Castello, a Monterosso Almo, che ha fatto la storia di Falcone e Borsellino, c’è Francesca Busacca, che con quest’associazione sta facendo delle cose importanti. Mi dà un piacere enorme il fatto che questo spazio continui al di là delle manipolazioni.
Trincale, in un testo raccolto in “Dieci anni di lotta”, nel distinguere la canzone popolare-proletaria da quella artistica-borghese, faceva un discorso di appartenenza di classe. Oggi che i confini tra le classi, a cinquant’anni dall’omologazione denunciata da Pasolini, sono saltati, si può parlare di musica popolare in riferimento alla tua attività di cantastorie? Cosa possiamo intendere oggi con l’espressione “canzone popolare”? Di quale popolo parliamo?
Domanda molto complessa. Dipende dall’accezione che noi diamo a “popolare”. Io sono rubieriano, gramsciano, cocchiariano e lombardi-satrianiano, nel senso che sul definire “musica popolare” quello che fanno Giovanna Marini e Francesco De Gregori in un cd pubblicato dalla Sony, Il fischio del vapore, ho delle esitazioni. Da un lato c’è la produzione del “popolare”, da parte di chi ha le leve per produrre; dall’altro il popolare prodotto da chi non ha le leve e si fa la chiavetta USB autoprodotta. Oddio, anche i cantastorie… perché Orazio Strano e Ciccio Busacca hanno inciso per la RCA. È un discorso complesso perché non è soltanto la questione della grande casa discografica. Se tu riuscissi a convincere la Sony a fare dei CD su contenuti di un certo tipo sarebbe un grande trionfo e i cantastorie questo l’hanno fatto. Il provocantore di Trincale è stato pubblicato dalla Fonit Cetra, oppure Matteo Salvatore, pugliese, che pubblicava per la Combo canti anti-latifondisti, antifeudali, scritti da lui. Non basta solo il fatto che la casa discografica sia una multinazionale per dire che non è popolare. “Popolare” si lega anche ai contenuti, è nel patto sociale che di volta in volta stringi con un presunto popolo. Per me “popolare” è scoprire cose che gli altri non dicono o che gli altri non hanno la voce o il coraggio di dire. Ma anche la mia storia: io sono professore universitario, figlio di un giornalista, media borghesia italiana, ho avuto questa occasione di avvicinarmi al mondo dei cantastorie e ne sono diventato continuatore in qualche modo. Io sono popolare o no? A Bari muore una badante di aborto naturale, pur di non rivelarlo ai medici, perché c'era il pacchetto sicurezza, quindi rischiava di essere accusata di essere clandestina. È la storia di un individuo ma questa Storia italiana di una badante bielorussa che io ho composto è evocativa di un mondo popolare. Io così lo intendo.
Come dicevi giustamente tu, le classi sociali oggi sono meno riconoscibili. Già allora era difficile capire cosa era popolare. Cos’è popolare? Al Bano, il neomelodico o il canto di Rosa Balistreri? È popolare Busacca che collabora con Dario Fo? O solo il Busacca delle piazze bracciantili? E il Busacca che si prestò a scrivere una storia sul Galbaliuni, un eroe di formaggio inventato da lui, pagato dalla Galbani per il promuovere il Galbanino in Sicilia dove non se lo comprava nessuno? È una parola che bisogna definire di volta in volta. Io la definirei nel senso di “scovare”, nel senso un po' verghiano della parola… (Verga era popolare? Lui scriveva per le grandi case editrici, a Milano faceva parte di un’intellighenzia legata alla Francia, eppure ha scritto romanzi in cui ha portato sulla scena drammi, come quelli de I Malavoglia, che non erano i quattro pescatori di Aci Trezza, ma quei quattro pescatori che si vedono distrutti dalla globalizzazione, dalla burocrazia piemontese, dai processi e dai profondi disagi suscitati dall’unificazione nazionale)... quindi “popolare” non è detto che debba essere fatto dal popolo. Gramsci diceva che quando le classi subalterne si approprieranno dei mezzi di comunicazione dell’alta borghesia allora la rivoluzione sarà fatta. “Popolare” è questo: fare in modo che la Rai, che paghiamo tutti, debba essere un luogo dove tutti siamo rappresentati, dove non fanno sempre i soliti Achille Lauro, De Gregori, Battiato e Sanremo. Prima accadeva. Ci trovavi Gaber, Dalla, Orietta Berti, Al Bano e poi ci trovavi Busacca e Buttitta in prima serata. Io parlerei di “canzone pubblica”, cioè sensibile a quello che avviene nel pubblico. Ad esempio, la storia del generale Graziano, presidente della Fincantieri, una delle più grandi industrie di armi, che si suicida perché un anno e mezzo prima gli è morta la moglie… c’è qualcosa che non quadra. Allora prendo questa storia di cui tutte le fonti non parlano e la faccio diventare io veramente popolare, faccio una ballata e la canto in tutte le piazze. La nozione di popolare non è sociale, è anche individuale ed etica: io porto al popolo ciò che i presunti “popolari” non portano e anzi censurano. Se invece tu ti spacci per “popolare” e poi assecondi il gusto populista dell’esotico, del mistico, del folklorico, dell’etnico fai un’operazione fraudolenta, che fa finta di dar voce e invece getta una pesante, retorica cortina di fumo sulla riflessione corale e sui suoi liberi effetti.

Associazione Culturale Il Cantastorie on line
sede: Milano - viale Beatrice d'Este 39
CF.97929380158
mail asso.ilcantastorieonline@gmail.com